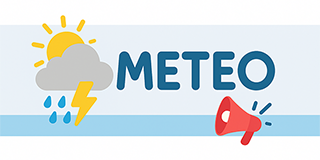AttualitàBiella
Jiuma sempi facc parej
Gli sbiellati, la rubrica di Lele Ghisio

Abbiamo sempre fatto così. Pare sia stata Grace Murray Hopper, donna del Novecento pioniera della programmazione informatica a cui tra le altre cose si deve l’uso del termine “bug” per definire un problema interno ai software, a dire e a scolpire nell’immaginario collettivo che quella all’incipit è la frase più pericolosa in assoluto. Eppure, a Novecento archiviato nei libri di storia e mentre stiamo nel pieno del prologo di un nuovo millennio, è frase ricorrente che fa eco di sé negli ambiti più diversi.
Sarà che, negli ultimi giorni, mi è rimbombata in testa un paio di volte in contesti differenti ed è poi rimasta lì a sedimentare riflessioni a perdere. Sarà per questo che ne scrivo improvvisamente e improvvidamente, rischiando di dire cose scontate a prezzo di saldo, o forse perché è un concetto che chi nasce da queste parti si trova tatuato sotto pelle, quasi fosse un peculiare codice genetico che prima o poi rilascerà in forma verbale in qualche momento della sua vita: “Jiuma sempi facc parej”.
Ho idea che, a far mente locale, ognuno di noi possa ricordare quando e come se lo è almeno sentito dire. Non importa dove: fosse in famiglia, azienda, impresa od organizzazione. Perché non importa nemmeno il come, che tanto il senso è lo stesso: chiudere la porta a un’opportunità nuova. È un’affermazione perentoria che trasuda un sottotesto che testimonia l’essere prevenuti a prescindere, portatori insani di un pregiudizio verso la novità. Figuriamoci nei confronti del diverso. Aveva, e ha ancora, ragione GMH: è un oggettivo limite mentale. Un po’ vivere il futuro come una minaccia, invece che qualcosa a cui tendere con curiosità.
Jiuma sempi facc parej: potrebbe essere questa l’estrema sintesi dello stato dell’arte del nostro territorio, che resta a trottolare su se stesso senza andare da nessuna parte. Potrebbe essere questo il lemma che esprime appieno l’attitudine locale a soffocare creatività e propensione al nuovo, sintomo di un miope conservatorismo che si traduce in immobilismo. Troppo spesso spacciato per tradizione, quando invece altro non è che bieca abitudine e zona di confort, come si usa dire e diceva persino Sant’Agostino: “L’abitudine a cui non facciamo resistenza diventa necessità”.
È così che si resta felici e frustrati della propria decadenza, immersi in un rinascimento nato morto. Intanto, se non cambiamo noi, cambiano gli altri modellando il futuro senza di noi. Un po’ come se usassimo ancora un telefono fisso a disco mentre il resto del mondo ha in tasca uno smartphone solo perché noi abbiamo sempre fatto così. O se il principio si applicasse in sanità: faremmo ancora prelievi di sangue con le sanguisughe attaccate al braccio. Figuriamoci poi se viene speso addirittura in ambito didattico: siamo senza speranza fin da piccoli, con una classe docente ferma al palo. Vedete bene che, se torniamo indietro di questo passo, pure l’inventore della ruota avrebbe avuto problemi con un così radicato istinto conservatore.
Si può azzardare qualche tentativo di motivare questa diagnosi con il timore della perdita di un privilegio, sotto forma dei bei tempi andati che bisognerebbe trovare il coraggio di lasciare andare per davvero, o con un qualche smarrimento dovuto alla temporanea perdita d’identità, problema identitario di chi affronta il nuovo se stesso con innata diffidenza e qualche paura.
L’innovazione tessile, nei termini di moda e confezione, di prêt-à-porter e branding, ce li siamo fatti soffiare sotto al naso inamidati com’eravamo e come spesso siamo nei nostri completi uomo. Non riusciamo nemmeno a essere curiosi, perché senza scomodare il pensiero laterale basterebbe un principio di curiosità a soffocare l’attitudine immobilista.
C’è anche un altro elemento che può essere utile a definire la nostra inadeguatezza alla sfida con il futuro: lo stigma del fallimento aziendale, o di un’idea e di un’impresa. Tendiamo a intendere e nascondere il fallimento come una vergogna e probabilmente ne traiamo pure un discreto godimento quando a fallire sono altri, mentre invece il fallimento è indice di vitalità imprenditoriale, necessità e inciampo visionario.
Di recente ho letto un interessante analisi sul nostro territorio e sulla sua economia che andava oltre la logica delle banalità correnti e suggeriva sincerità e autocritica per tornare davvero a scommettere sul futuro biellese: basta con «l’impulso di rifugiarsi in alibi giustificativi». E autoassolutori aggiungerei, ma la verità ci fa male lo so.
Jiuma sempi facc parej definisce la nostra indole di boomer impettiti, tanto per usare un linguaggio corrente dalle sfumature pop, e “suma facc parej” non è un alibi che regge. Possiamo essere altro, dobbiamo essere capaci di essere altro. Con meno nostalgia canaglia e più curiosità. Che tra l’altro è femmina, e questo non è per niente male. Checché se ne dica.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook