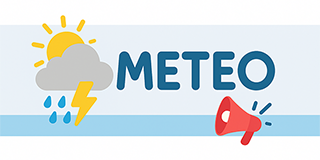Attualità
Mai una gioia

BIELLA – Non so proprio da dove cominciare. Proviamo da qui, dai ricordi. Solo due, vaghi e sfumati come spesso lo sono nei flashback delle serie tv. Ero piccolo, troppo piccolo per poterli definire meglio nei contorni e farne ora una memoria compiuta: una zia giovane e bellissima, con la cornice della piccola cucina dei nonni; una cassa di legno e la mano di qualcuno che mi teneva stretto. Basta, fine dei ricordi.
Accanto alla tastiera da cui scrivo, c’è una fotografia: di lei, sorella di mio padre e mia madrina, che mi tiene in braccio il giorno del battesimo. Sto facendo fatica, prendo tempo: bevo un sorso di vino rosso, espiro una voluta di fumo. Mi fa un po’ male, forse perché è una vicenda che non ho mai raccontato, e nemmeno mi sono mai raccontato per bene. Una ferita dolorosa, che ha segnato per sempre la storia della mia famiglia.
Quella cassa di legno, non so bene se contenesse il suo giovane corpo o le sue cose. Perché è così che lei tornò dalla Somalia: in una cassa di legno. Addetta all’ambasciata, viveva a Mogadiscio e lì morì a 28 anni, vittima di una malattia tropicale, in una Somalia da poco emancipata dai poteri coloniali, dalle nostre colpe e dalle nostre virtù, come le tracce che lasciano ogni vicenda coloniale che si rispetti.
Di tanto in tanto mi capita di rileggere le lettere che scriveva a mio padre e che ho conservato. Parole dolci e d’affetto, battute a macchina sulla carta velina ripiegata che all’epoca la posta aerea esigeva. Conservo ancora i francobolli. Suo marito, mio zio, fu poi costretto a fuggire da lì negli anni ’90. La situazione si era fatta pericolosa e insostenibile per qualsiasi “occidentale”. Lasciò tutto e tornò in Italia, a Roma. Non lo vedo da tanto tempo.
È anche per questo che qualche giorno fa, alla notizia battuta dalle agenzie di stampa della liberazione e del ritorno di Silvia Romano, ho provato una gioia che avevo dimenticato da qualche parte. Sono stato felice come un bambino a rivedere il suo sorriso, felice probabilmente come il bambino che ero stato allora e del quale non ricordo bene le felicità.
Dopo tre mesi di morte e desolazione sociale una gioia. Vera, inattesa. Ho passato qualche giorno a smaltirla e a cercare di conservarne traccia nel quotidiano. Che di gioie ne ha bisogno, sempre. Eppure no. A qualcuno quella gioia pura non stava bene. E non ha visto il suo sorriso, non si è stretto in quell’abbraccio familiare che solo qualche dio sa quanto mi manca, e quanto e quante volte ho riguardato quelle immagini per sentirne almeno un poco il calore.
Eppure no. Eppure qualcuno teneva gli occhi puntati sui suoi abiti e sulle proprie miserie. Lo hanno fatto tutti coloro che, a lei liberata, hanno rapito la gioia e la tengono in ostaggio della loro aridità. Fino a farmi sorgere l’orribile pensiero che l’abbiano trattata peggio dei suoi veri rapitori. Come fosse invidia del bene, con la necessità e l’insana voglia di giudicare sostituita alla voglia e alla necessità di salutarla e stringerla forte.
Ma lei è viva e avrà tempo di perdonarci. Perché siamo tutti colpevoli, anche in questa città che si ostina a vivere la favoletta dell’isola felice e invece si riscopre ogni volta come tutte le altre. Una città in cui sindaci e vicesceriffi così prodighi d’esternazioni inutili non spendono una parola per lei, non ritenendolo politicamente opportuno; una città in cui nemmeno il sito istituzionale spende una parola di saluto, un moto gioioso. Per lei che dalla Somalia non è tornata in una cassa di legno.
Una città in cui, tra i tanti, un ex assessore provinciale aizza la sua bolla social di commentatori come cerberi bavosi e gode di quella meschinità. Cancella il gentile epiteto “troia” e lascia il suo corrispondente dialettale, che dà meno nell’occhio ma odora della stessa merda. O, tra i tanti, segretari locali di partito che gioiscono sì, ma solo se a quel bellissimo sorriso ci stampano sopra il logo della ditta.
Forse questo Paese e questa città una gioia così non se la meritano: fossi in lei, a tutti quelli che l’hanno giudicata in preda alle loro miserie, suonerei il citofono per restituirgli il sorriso che hanno perso e che lei ha ritrovato.
Rosanna, mia zia si chiamava Rosanna. Domani le porterò una rosa. E la chiamerò Aisha.
Lele Ghisio
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook