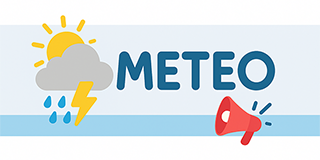AttualitàBiella
C’è di peggio nella vita che morire
Gli sbiellati, la rubrica di Lele Ghisio

Non è facile. No, che non lo è. Non è facile ogni settimana trovare cose da dire, che abbiano un senso e interessino almeno a un paio di persone oltre a chi scrive. Non è facile soprattutto trovarne che abbiano attinenza geografico-emozionale con questa città e quel che le sta intorno, frazioni comprese. A volte la cronaca locale, bianca o nera che sia, fornisce buoni spunti. A volte vince l’inedia apatica della provincia profonda.
C’è chi ricorre allora a un ingenuo strattagemma: prende un argomento nazionale o internazionale a caso, più o meno interessante, infila dentro al testo un “Biella” o uno degli aggettivi derivati e procede come se nulla fosse, fischiettando tra le righe. Tipo: un abitante del Belize uscendo di casa scivola su una buccia di banana, e si commenta l’accaduto giustificandosi con il fatto che anche a Biella si mangiano le banane. È un paradosso, ma è utile per farmi capire meglio e magari farvi cercare online dove si trova il Belize. Del resto è veramente difficile che in Belize sappiano dov’è Biella, quindi fatelo pure a cuor leggero.
Resta il fatto che vedere cosa succede fuori può essere utile a guardarsi dentro, cosa che noi biellesi facciamo con una certa difficoltà. Oppure che guardarsi dentro, quando ci capita di farlo, può essere utile se comprendiamo che facciamo parte di un contesto e non siamo certo quell’isola, felice o infelice che sia, che spesso pretendiamo d’essere.
Facciamo che oggi mi gioco una sorta di jolly e approfitto di questa pratica per rendere un omaggio, un tributo, un riconoscimento a uno scrittore che con Biella c’entra poco, ma qualcosa c’entra. Mi è venuto di farlo perché giusto questa settimana è uscita la ristampa, in nuova edizione ampliata, del suo ultimo romanzo: “Works” (Einaudi). Biella c’entra dicevo, perché è a Biella che l’ho conosciuto. Correva l’anno 2017 e proprio Works era nella cinquina di finalisti del Premio Biella letteratura e industria. Che, giustamente, a questo dovrebbero servire i premi letterari: a far conoscere scrittori.
Nel riportare su questo giornale la cronaca della presentazione al pubblico dei cinque autori dichiarai fin da subito il mio entusiasmo per lui, che calò come un extraterrestre sul piccolo palco della biblioteca di Città Studi, allestito alla bisogna per l’intervista rituale ai finalisti, stravolgendone in modo inconsapevole la stanca liturgia. A risvegliare il pubblico, un poco assopito dalla chiacchiera, fu proprio, paradossalmente, la sua non-intervista: un’assenza verbale che spiegava, con imbarazzata postura e monosillabico interloquire, l’inutilità delle parole da fare su un libro già scritto apposta.
Un imbarazzo difficile da decifrare, tanto da chiedersi fino a che punto fosse posa o realtà. Ma i suoi sì e i suoi no, quelle lunghe pause di silenzio certificavano anche la sua essenza di scrittore: diretto, senza fronzoli. Perché proprio con la sua scrittura inventava una poetica di pause e di silenzi, il ritmo di una ruvida alterità rispetto a ogni cosa già letta. Tutto questo risaltava in quella sala per contrasto tra proposte letterarie più o meno interessanti, ma spesso borghesi autobiografie della nobiltà d’impresa, compiacenti narrazioni agiografiche di figli che raccontano padri o cose del genere.
Works parlava allora, ma parla ancora oggi, del lavoro e delle sue quotidiane contraddizioni di sopravvivenza. Lo fa col piglio autobiografico che ha caratterizzato tutta l’opera di Vitaliano Trevisan: scrittore, sceneggiatore, drammaturgo, persino attore e musicista. Veneto, vicentino, dal carattere introverso e dall’ironia necessaria per fare un po’ pace con le parole e le storie, e, perché no, con sé stesso.
Ha raccontato i suoi luoghi, quella provincia del Nord-Est così piena di senso perduto, come non ha mai fatto nessuno; con la prosa bop del ritmo che batte a fondo pagina, tra una nota e l’altra, tra una citazione e l’altra, sorta di metatesto che allude, integra, riporta, sposta e rimette in ordine il racconto. Perché, direbbe con parole sue: “in fondo gli stavo dando proprio ciò che mi avevano chiesto, cioè il mio parere di esperto, e se c’è una cosa di cui sono esperto è il dubbio” (da “Tristissimi giardini”, Laterza). E che “scrivere un libro è un po’ come cantarsi una canzone, a quale tonalità e tempo non importa; l’essenziale è essere intonati e a ritmo con sé stessi” (da “Works”).
Quell’intonazione tra sé stesso e il mondo che comunque Trevisan faticava a trovare, e difatti: “tutta la sua opera è segnata dalla pena e la sua rimuginazione: Trevisan è forse lo scrittore italiano che meglio ha saputo raccontare il dolore esistenziale contemporaneo”, come riporta un estratto da un breve saggio letterario a lui dedicato, risalente a qualche anno fa. Vitaliano Trevisan è morto suicida all’inizio di quest’anno. E se vi capiterà di leggere “Works”, ci troverete scritto: “C’è di peggio nella vita che morire”.
Lele Ghisio
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook