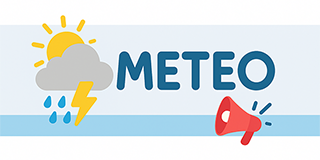BiellaLei non sa chi sono io
Lei non sa chi sono io: Luigi Sturzo
La rubrica con cui Edoardo Tagliani racconta i titolari delle vie cittadine

«A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della Patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà».
È il 18 gennaio del 1919. Il Fascismo è in ascesa. Un giorno di svolta per l’Italia e persino per il Vaticano.
Don Luigi Sturzo (Caltagirone, 26 novembre 1871 – Roma, 8 agosto 1959), fonda il Partito Popolare Italiano (PPI) lanciando il manifesto “Appello ai liberi e ai forti”.
È il primo atto politico ufficiale (enorme) di un cattolico dopo il “non expedit”, la disposizione della Santa Sede emanata nel 1886 che dichiarava inaccettabile la partecipazione dei fedeli alla vita politica del Regno, disposizione revocata da Benedetto XV proprio all’inizio del 1919.
Correva il 1922 quando il PPI, dopo la marcia su Roma, decise di appoggiare il neonato governo Mussolini, ma nel congresso di partito del 1923 fu proprio Sturzo a far prevalere la tesi dell’incompatibilità tra concezione popolare dello stato e Fascismo: Mussolini non la prese benissimo, tanto che scatenò una campagna politico-mediatica contro quello che definì “il sinistro prete”.
Alla fine di un’intensa attività del regime, che isolò Sturzo anche in Vaticano e lo costrinse a dimettersi dal partito, il fondatore del PPI fu costretto all’esilio. Dal 1924 al 1945 trovò rifugio tra New York, Londra e Parigi, continuando la sua attività politica assieme alle comunità italiane residenti in quei Paesi.
Rientrò in Italia nel 1946, sbarcando a Napoli. Continuò un’intensa attività politica pur non aderendo mai formalmente alla Democrazia Cristiana. Rifiutò incarichi romani e venne nominato giudice dell’Alta Corte per la regione Sicilia, incarico che di fatto lo riportò davvero “a casa”. Poi, invece, in Capitale dovette tornarci nel 1952, quando Luigi Einaudi lo fece senatore a vita, carica che ricoprì sino alla morte.
Primo fra tutti a coniare l’ormai emblematica espressione “questione morale”, rimase sempre sostenitore di alcuni principi cardine. Tra i tanti, due su tutti: la persona al centro di tutto («la base del fatto sociale è da ricercarsi nell’individuo») e il valore di una politica aconfessionale («L’individuo deve scegliere da sé se seguire la propria coscienza di buon cittadino o di credente; non è la Chiesa che deve indirizzarlo nell’atto della scelta, la quale attiene strettamente alla sfera individuale del singolo»).
Nel novembre del 2017 si è conclusa la fase diocesana per la sua beatificazione. Monsignor Slawomir Oder, che ha presieduto il percorso, ha dichiarato: «Speriamo di chiamarlo presto santo».
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook