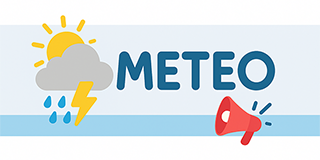Gli Sbiellati
Faccia a faccia con l’assassino

BIELLA – Conseguenze irreversibili. Un concetto che ricorre nel film “No me llames Ternera”, disponibile su Netflix. Il documentario, presentato tra le polemiche al Festival del cinema di San Sebastián, è centrato sull’intervista a un dirigente Eta (organizzazione terroristica basca, attiva tra il 1959 e il 2018): Josu Urrutikoetxea ”Ternera”, colui che annunciò pubblicamente la sua definitiva dissoluzione. Polemiche che fatichiamo a comprendere, ma nei Paesi Baschi e, più in generale, in Spagna la ferita è ancora aperta.
Nei suoi sessant’anni di storia, Eta ha causato la morte di 864 persone: queste sono le conseguenze irreversibili, secondo lo stesso Ternera. Un concetto eufemistico che lui esprime tentando di dare un contesto ideologico e politico alle azioni della banda, ma che finisce per ben definire il dolore familiare e sociale causato da queste morti: irreversibile.
A ragionare su questa ineluttabile condizione è anche il film “Una donna chiamata Maixabel”. Distribuito nelle sale italiane lo scorso luglio. È la storia vera di Maixabel Lasa, rimasta vedova nel 2000, quando Eta uccise il marito. La storia della vita oltre quella morte.
Due citazioni per affrontare un tema delicatissimo: quello della “conseguenza irreversibile”, a sua volta causa del dolore irreversibile, a cui sono condannati i genitori di Erika Preti. Un dolore violato a novembre quando per l’assassino della figlia sono stati disposti gli arresti domiciliari per affrontare con le cure necessarie il suo precario stato di salute. Un dolore violentato più di recente, quando il padre si è trovato faccia a faccia con lui in città.
L’indignazione ha preso il sopravvento, nonostante gli fosse legalmente concesso il permesso quotidiano di tre ore per affrontare il processo di cure e le sue necessità. I genitori hanno dato sfogo alla frustrazione con comprensibili dichiarazioni pubbliche, alle quali sono seguite altrettanto comprensibili, ma meno giustificate, dichiarazioni non richieste di commentatori da bar e da social.
Tutte forcaiole: cosa ci fa ai domiciliari se poi va in giro; solo in Italia; questa non è giustizia; in galera e poi gettiamo la chiave; in galera ci manderei quel giudice; se ci fosse la pena di morte. Tutte istanze lontanissime dalla concezione di vivere in uno Stato di diritto, condizione alla quale siamo arrivati oggi, dalle origini dell’uomo, in un lento progredire. Tant’è che tacciamo d’inciviltà quei popoli che ancora non l’hanno introdotto nel loro ordinamento per motivi politici o religiosi.
La giustizia infatti non può coincidere con la vendetta sociale: è roba da barbari, oltre a essere un deterrente inefficace come la storia ci insegna. Il giudice che ha disposto il provvedimento lo ha fatto rispettando leggi e pareri medici, perché anche da detenuti si è detentori dei diritti umani e quello alla cura, se non è possibile in carcere per carenza di strutture, lo è.
Resta comprensibile invocare almeno la certezza della pena da parte di chi invece ha la certezza delle sue personalissime pene. Quindi come non esprimere vicinanza a quei genitori che incrociano per la città l’assassino della figlia dopo soli quattro anni di carcere. C’è da chiedersi se non fosse stato possibile imporgli un diverso domicilio, altrove.
Il punto sul quale volevo soffermarmi però è, fondamentalmente, un altro. Quello relativo all’elaborazione sociale dell’essere vittime e non volersi considerare tali per tutta la vita. La citazione di Eta in incipit non è casuale: quella vissuta dai genitori di Erika è situazione quotidiana per chi vive nei Paesi Baschi, ci parla di familiari costretti al confronto con i carnefici dei loro cari. Grazie al fine pena o ragioni simili.
A Maixabel Lasa hanno dedicato un film perché è stata un esempio di reazione al dolore: per oltre dieci anni è stata direttrice del dipartimento che, per il Governo basco, si occupa delle vittime del terrorismo. Lo ha fatto dando pari dignità a quelle di Eta, del terrorismo di Stato e degli abusi delle forze di polizia. È stata la prima vittima a voler incontrare gli assassini del marito, dando il via al processo di giustizia riparativa su cui si fonda l’elaborazione sociale di quel lutto.
Non si parla di perdono, che è un concetto essenzialmente religioso e quindi soggettivo, ma di una soluzione di convivenza, di una seconda possibilità per le vittime e per chi ha commesso quel crimine e vorrebbe tornare a far parte della società civile. In Italia ne abbiamo un rigoroso esempio in Agnese Moro, una delle figlie di Aldo Moro, assassinato dalla Brigate Rosse nel 1978, che ha intrapreso, grazie anche alla riforma Cartabia, un significativo percorso di giustizia riparativa incontrando gli assassini del padre. È un non facile percorso sociale di civiltà. Ci vuole tempo, per un’elaborazione di questo tipo, tempo maledetto perché passato a fare i conti con l’assenza e la sua irreversibilità. Ma quei conti, prima o poi, vanno fatti.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook