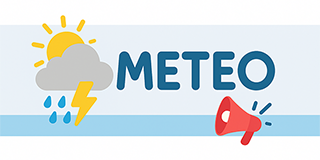AttualitàBiella
Adunata Alpini Biella 2025 – LA STORIA DELL’ALPINO E DEL MULO SCUDELA, IL MONUMENTO AI CADUTI
Giardini Zumaglini

Il monumento ai Caduti della Città di Biella nella Grande guerra, inaugurato nell’area orientale del giardino pubblico il 13 ottobre 1923, è una scultura di bronzo che l’autore, Pietro Canonica, intitolò Il ritorno vittorioso.
Il Canonica volle che sullo sfondo fosse piantata una cortina di alberi, tale da nascondere la vista degli edifici di via Mazzini. Scelse quel luogo del giardino perché, in lontananza, si potessero vedere le montagne, ma la costruzione dell’imponente palazzo Ronco alle spalle del monumento, iniziata nel 1925, guastò lo scenario realistico voluto dallo scultore.
L’alpino e il mulo Scudela
Il mulo ritratto dal Canonica ha un nome: Scudela. Fedele compagno dell’alpino, era il mulo più resistente e coraggioso del battaglione. L’alpino voleva bene a Scudela: gli dava da bere acqua fresca e pulita, curava in tutti i modi che avesse una buona razione di fieno e di avena; lo faceva riposare, quando possibile, su terreno senza pantano; non gli faceva male con la striglia, non faceva strappate alle redini, lo governava con dolcezza e, alla fine del duro giorno, prima si occupava del suo mulo, poi di se stesso. Scudela lo ricambiava, voleva bene al suo conducente, ne comprendeva ogni gesto e parola.
Quante fatiche su dirupi e ghiacciai, con in groppa il cannoncino per gli aspri sentieri di montagna, sotto la neve e il fuoco nemico! Assieme soffrivano, assieme riposavano, assieme accettavano ogni rischio.
Una mattina la montagna fu sotto un intenso fuoco nemico; tutti tornarono alla base, tranne Scudela e l’alpino, che furono dati per dispersi. Era quasi notte, quando il mulo raggiunse il campo senza il suo milite, di cui rimaneva sul basto il cappello con la penna nera.
Dopo la guerra, l’Esercito decorò Scudela con medaglia al Valore, con lui rendendo omaggio anche all’alpino mai più tornato. La medaglia era un riconoscimento anche al mezzo milione di muli coinvolti nella Grande guerra. Gli animali soffrono con noi e per noi.
L’idea di un monumento
Nell’opera di Pietro Canonica gli occhi dell’alpino fissano un punto dell’orizzonte alla sua destra: là dove è il suo destino e dove il pensiero del monumento nasce. Laggiù, nell’antica stazione Biella-Santhià di via Lamarmora, la mattina del 23 ottobre 1921 arrivarono i feretri con i resti di quattro giovani biellesi decorati con medaglie al Valore. Nella camera ardente, concessa dalla Direzione della Ferrovia, furono deposte le quattro bare, avvolte col tricolore. Una lunga teoria di gente sfilava dinnanzi ai feretri e ogni mano lasciava cadere un fiore (La Tribuna Biellese, 26 ottobre 1921). Alle nove precise, le salme, portate a braccia dai compagni d’arme dei Caduti, uscirono nel piazzale della stazione. La musica intonava la poetica e nostalgica canzone del Piave. Due affusti, trainati da cavalli bardati, sfilarono tra le ali di una folla silenziosa: sul primo le salme di Costantino Crosa e di Renato Quazza; sul secondo quelle di Mario Cucco e di Alessandro Ferraris. Aleggiava un senso di pace profonda, contrariamente ai timori della vigilia. Il corteo, passando per via Umberto (oggi via Italia), raggiunse piazza Quintino Sella (oggi piazza Martiri) e qui si raccolse la città, non meno di 25.000 persone (La Tribuna Biellese, 26 ottobre 1921). Davanti al Liceo Ginnasio, ove era stato studente Mario Cucco, parlò il prof. Ruggero Battistella, che nei cimiteri del Grappa e del Piave aveva prelevato e composto le salme del suo alunno e degli altri tre giovani, per portarle a Biella. Dopo aver abbracciato in un pensiero commosso tutti quelli che, alleati o nemici, avevano sacrificato la vita sulle insanguinate montagne, il professore, rivolgendosi alle anime dei quattro giovani, coscienti del dovere sino al sacrificio estremo, gridò: “Ora che sono restituite le vostre salme alla terra natia, che cosa avete da dire fra voi, e che cosa volete dire ai vostri biellesi concittadini? Le vostre figure, alte e nobili, si elevano fieramente sopra il verde di questa terra industriosa e buona. Uniti dalla coscienza del dovere compiuto sino al sacrificio, questo voi volete dire ai vostri concittadini in nome di tutti i Morti della grande guerra, per l’amore che Cristo insegnò agli uomini, per tutti i mali che affliggono l’umanità: ‘Pace! Pace e lavoro alle genti affaticate e stanche! Pace, lavoro e concordia su questa aiuola che ci fa tanto feroci!’” (La Tribuna Biellese, 26 ottobre 1921).
Dopo le splendide parole del prof. Battistella, la Banda Cittadina, che con la Banda Verdi, la Banda dell’Ospizio di Carità e la Fanfara del Circolo Excelsior aveva prestato servizio nel corteo, fece echeggiare ancora l’inno al Piave. Poi le bare di Crosa e di Cucco proseguirono per Oropa, quella di Quazza per Mosso S. Maria e quella di Ferraris per Masserano. A questo punto il cronista nota che la folla, in un impeto di amore irrefrenabile, rompe i cordoni e circonda le sacre salme che partono per il riposo ultimo, presso i quieti cimiteri montani di nostra terra (La Tribuna Biellese, 26 ottobre 1921).
Il comitato per un monumento
Il 4 novembre 1921 furono celebrate nella medesima piazza, come in molte altre d’Italia, le onoranze al Milite Ignoto nel terzo anniversario della Vittoria. Intanto, lontano dalle tensioni tra opposte fazioni, un “Comitato” (presidente Amilcare Strona), sospinto dallo spirito di pace che aveva aleggiato sulle esequie dei quattro giovani, aveva aperto una sottoscrizione per un monumento ai Caduti della Città di Biella e nominato una “Commissione artistica”, che il 6 dicembre 1921 bandì un concorso nazionale per una scultura che non ispirasse sentimenti di odio o di rabbia, ma serena umanità e senso del dovere, virtù capaci di illuminare anche il tempo della pace. E che non fosse esibizione di strazio o di angoscia, perché il dolore non si esibisce. E nemmeno allegorica astrazione, ma una cosa viva come le piante che le sarebbero cresciute attorno, in quell’ala orientale del giardino pubblico coltivata ad aiuole e contornata da viali. Nell’aprile 1922 furono ritenuti inadeguati i 44 bozzetti ricevuti: Vittorie alate, Eroi martirizzati, Nidi d’aquila, Fanti dal volto truce, Glorie, Altari e Apoteosi assortite. Nell’ottobre 1922 esito simile ebbe un secondo concorso, a cui parteciparono 15 bozzetti. Il “Comitato”, consigliato dalla “Commissione artistica”, si rivolse ad alcuni tra i più noti scultori italiani, ma il costo non doveva superare le 200.000 lire, frutto della pubblica sottoscrizione. In una situazione di stallo, nel dicembre 1922, Pietro Canonica, già presidente della “Commissione artistica”, cedette agli insistenti inviti e si accinse all’opera.
L’inaugurazione
Sabato 13 ottobre 1923, poco dopo le ore 14, alla presenza di re Vittorio Emanuele III e di una folla straripante, un piccolo orfano di guerra tolse il velo al monumento. La sera di quel giorno il giardino pubblico era illuminato ovunque da ghirlande di luminarie. E, quando arrivò la notte, sempre nuovi gruppi di cittadini accorrevano ad ammirare l’alpino e il mulo, mentre il vento faceva volare le gialle foglie. L’alpino caduto si era ricongiunto al fedele Scudela, ancora per un attimo. Ieri, oggi e ancora per un attimo.
Gianfranco Ribaldone
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook